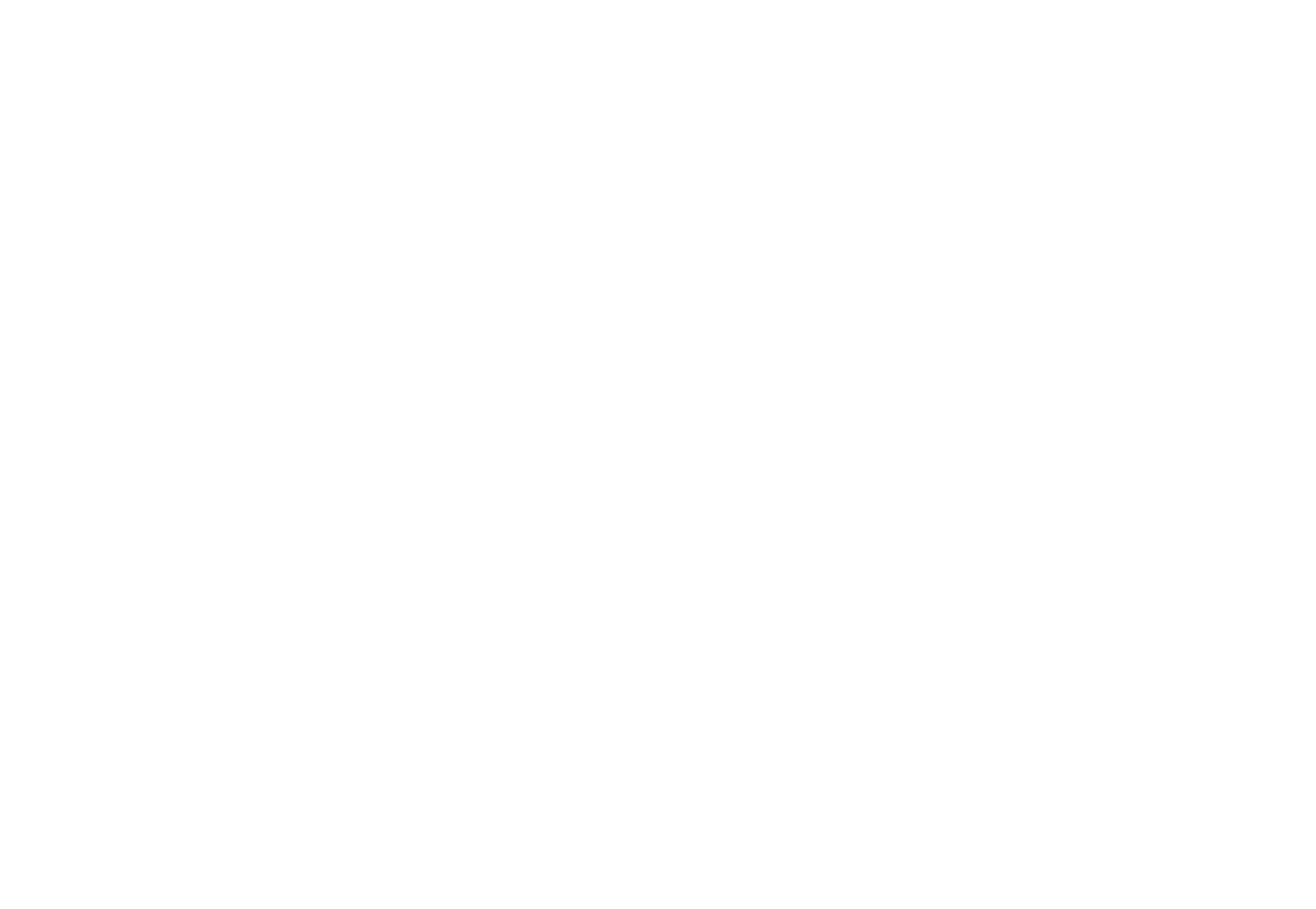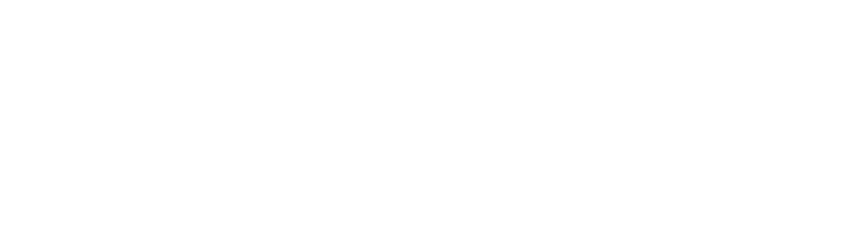mica solo gli orange!
I colori delle nazionali non sono scelti a caso, lo sappiamo. Sono bandiere cucite sulla pelle, pezzi di storia che diventano leggenda ogni volta che un inno risuona negli stadi. Gli Orange, certo: l’Olanda s’illumina dell’arancione regale degli Orange-Nassau, e gli spalti diventano un carnevale monocromatico ogni volta che scendono in campo. Ma se vi fermate lì, a guardare solo il Nord, vi perdete il vero spettacolo. Perché basta scendere un po’, oltre i tetti grigi e le biciclette di Amsterdam, per trovare un altro colore capace di accendere il cuore: l’azzurro.
L’Azzurro d’Italia. Quello vero, quello che affonda le sue radici in un tempo in cui le dinastie parlavano latino e le bandiere avevano un’anima. Il colore della casata dei Savoia, sì, ma anche — e forse soprattutto — il colore del mantello della Vergine Maria, a cui la dinastia era devotissima. Insomma, roba seria, roba che mescola fede, storia e identità. Non è solo un colore: è una vocazione.
Per quella maglia azzurra, ogni italiano spera, soffre, esulta. Ogni atleta la desidera come si desidera un amore impossibile: ci si allena, si lotta, si cade, si prega. È un voto laico a una divinità sportiva. E in un particolare momento della sua storia, anche se fuori spicca il tricolore, dentro, proprio lì sull’etichetta interna, c’è un dettaglio curioso: un galletto. Eh già, Le Coq Sportif.
Ironia della sorte, o forse solo uno splendido paradosso del destino: il simbolo della Francia a cucire le gesta dell’Italia più bella. Nel 1979, il brand francese subentra all’Adidas nella sponsorizzazione tecnica e cuce l’azzurro addosso agli eroi che scriveranno una delle pagine più indimenticabili del calcio mondiale.
Nel laboratorio di Roilly-sur-Seine, nel cuore della regione dell’Aube, Émile Camuset — che non faceva bollicine ma maglie in jersey per sportivi — aveva cominciato tutto nel 1882. Giusto un secolo prima di quella notte magica a Madrid. Coincidenze? Forse. Ma cent’anni dopo, in quello stesso 1982, Le Coq veste gli Azzurri. E non li veste soltanto: li esalta.
Dimenticate le maglie anonime: nasce la leggenda. Una maglia metà cotone e metà poliestere, leggera come il sogno di un bambino e forte come il grido di un popolo. Cambia il colletto, che diventa a polo — elegante, quasi regale — e arrivano i primi dettagli tricolori su maniche e colletto, un segno d’identità che durerà fino a Italia ’90. Lo scudetto si aggiorna anch’esso, con la sigla FIGC incastonata nel bianco, come a dire: qui dentro c’è l’anima del nostro calcio.
Quella è la maglia di Paolo Rossi, dell’urlo di Tardelli, della corsa impazzita di Altobelli. È la maglia che si impregna di sudore e gloria, mentre l’Italia alza la Coppa del Mondo e un’intera generazione si sente invincibile.
E proprio lì, su quell’erba umida del Bernabeu, c’è Rossi steso a terra, gli occhi al cielo, ubriaco non solo di felicità ma anche — come dirà lui stesso — di una pioggia di champagne. Il cerchio si chiude, in un certo senso: dalla maglia cucita in una terra di bollicine, fino al trionfo inondato da esse.
E allora sì, mica solo gli Orange. Perché ci sono colori che raccontano molto più di una squadra: raccontano chi siamo. E l’Azzurro, per l’Italia, è questo. Un atto d’amore, una promessa al cielo. E una maglia che, anche oggi, sa ancora farci venire la pelle d’oca. Sotto un ordito e una trama di poliestere e cotone.

IL PRINCIPE AZZURRO, LA MAGLIA AZZURRA E QUELLA PROMESSA DA BAMBINO
C’è un sogno che appartiene a tutti, ma proprio a tutti. Non fa distinzioni tra chi gioca sull’asfalto scrostato del cortile sotto casa e chi calca i prati perfetti degli stadi internazionali. È un sogno che si accende da bambini, davanti a una televisione, accanto a un nonno o a un papà, con le ginocchia sbucciate, la maglia troppo larga e la bandiera tricolore stretta tra le mani: giocare per l’Italia. Indossare l’azzurro. Vincere la Coppa del Mondo.
È il nostro "c’era una volta", la favola a cui nessuno rinuncia. Solo che invece del cavallo bianco, qui si corre su due gambe, e il principe azzurro ha i parastinchi, le scarpette e l’inno nelle orecchie. La Coppa del Mondo? È la principessa da conquistare. E la maglia della Nazionale è quella corazza magica che rende invincibili — o almeno, così crediamo da sempre.
Quando si parla di Nazionale, in realtà si parla di ben altro. Della Coppa, quella vera. Perché lo sappiamo tutti, che il cuore batte più forte quando si gioca il Mondiale. Perché è lì, sotto quel cielo pieno di bandiere, che l’Italia intera smette per un attimo di dividersi tra Juve, Inter, Milan o qualunque altra fede, e si ricorda che, in fondo, siamo un popolo solo. Uniti. Per novanta minuti (più recupero). E se si vince, si vince tutti.
“Quando si indossa quella maglia, si è pronti a morire per onorarla.”
Parole pesanti, scolpite nel cuore di chi il campo lo conosce davvero. Perché la Nazionale non è una semplice convocazione. È un passaggio di consegne tra generazioni, è sentirsi parte di una storia lunga, gloriosa, a volte sofferta. È l’apice di una promessa fatta da bambini, con le mani appiccicose di gelato e gli occhi pieni di Pelé.
Come Paolo Rossi, quando nel 1970 guardava Italia-Brasile con suo nonno Giovanni. Seduti in salotto, con le poltrone sempre al loro posto, come se l’amore per la maglia azzurra avesse un rituale sacro. E quando l’Italia perse quella finale, Paolo non dimenticò. Non dimenticò le lacrime. Non dimenticò la promessa. “Il Brasile pagherà questo affronto,” disse. “Lo farò per te, nonno.”
Quella scena è un gioiello incastonato nella storia del nostro calcio. Tenero come l’abbraccio del nonno, epico come il bacio sulla fronte. E umile — come lo fu quell’intervista che Giampiero Galeazzi fece a Paolo Rossi dopo il trionfo dell’82. Niente frasi da eroe. Nessuna posa da star. Solo due uomini, stanchi e felici, con negli occhi una gratitudine enorme. Galeazzi, con la voce che tremava più del microfono, e Rossi, che sembrava ancora quel bambino con i pantaloni corti. Il principe azzurro, finalmente a cavallo del suo sogno.
E allora sì, parliamo di Mondiali. Perché ogni volta che suona l’inno e sventola il tricolore, torniamo bambini anche noi. Rivediamo i nostri nonni, i nostri salotti, le nostre promesse segrete. E forse non tutti ce la faranno ad alzare quella Coppa, ma tutti possiamo vivere la magia di inseguirla.
Perché l’azzurro non è solo un colore. È uno stato d’animo. È un patto antico che passa per le lacrime di un bambino, l’abbraccio di un nonno e le parole di un eroe che ha saputo essere grande con la stessa umiltà con cui era partito.
E se non è una favola questa, allora davvero non sappiamo più cosa lo sia.